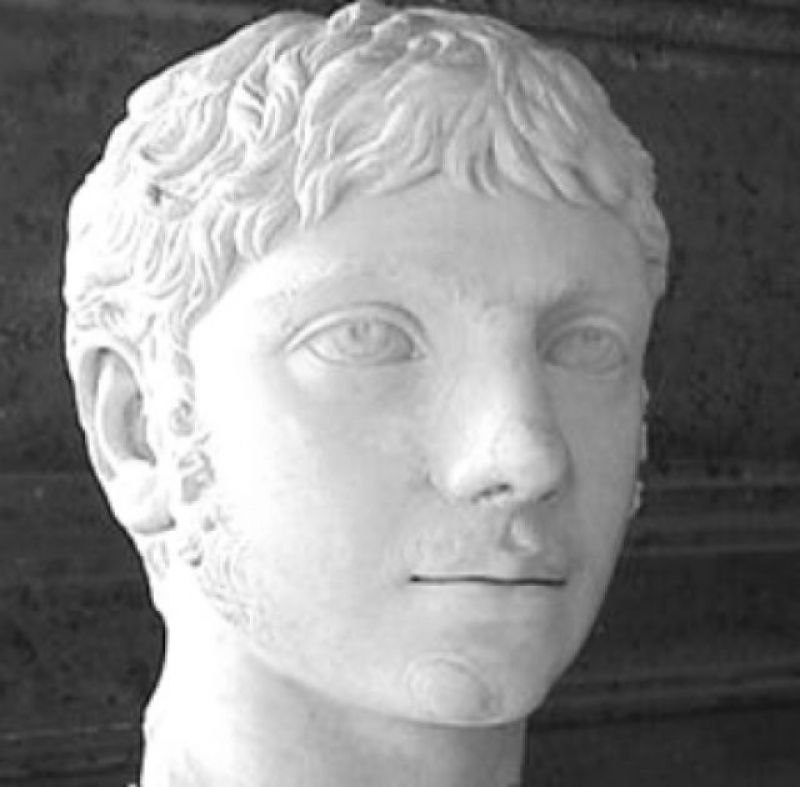Il famoso detto “Tutte le strade portano a Roma” non era semplicemente un modo di dire ai tempi della Roma Antica.
Generalmente i Romani con il termine Via intendevano le strade extraurbane che partivano da Roma e collegavano tutte le provincie dell’Impero.
Come venivano scelti i nomi delle strade nella Roma Antica?
C’erano diversi modi per scegliere i nomi delle strade: a differenza di quello che avviene oggi (dove i nomi delle strade sono più che altro un omaggio a personaggi famosi siano essi politici o scrittori) i Romani avevano un modo piuttosto pratico per indicare i nomi delle vie.
Principalmente il nome di una via veniva scelto seguendo tre criteri: poteva essere il nome della destinazione finale della strada (come ad esempio la Tiburtina o la Tuscolana); veniva dato alla strada il nome del console che la aveva costruita (come ad ese
pio l’Appia o l’Aurelia); infine, il nome poteva indicare il fine della strada (la Salaria, ad esempio era la “via del Sale”).
Le strade di Roma erano delle vere e proprie autostrade del tempo, il tragitto veniva studiato con la massima cura ed erano costruite in modo da poter raggiungere ogni destinazione nel più veloce tempo possibile.
Il percorso era rettilineo, gli ostacoli della natura era superati utilizzando l’ingenium: se c’era un fiume venivano costruiti dei ponti, se c’era una collina si realizzava un traforo, anche se in alcuni casi gli ingegneri decidevano di eliminare del tutto l’ostacolo, stando sempre attenti a rispettare il paesaggio, deturpandolo il meno possibile (cfr. a questo proposito di GIULIA FIORE COLTELLACCI, I segreti tecnologici dei Romani, pp. 17 e segg.).
Le strade erano abbastanza larghe da consentire il passaggio a due carri nei due sensi di marcia opposti e la pavimentazione veniva costruita in ciottoli per consentire una maggiore stabilità e drenaggio del terreno.
Le arterie principali erano addirittura costruite con pietre poligonali – il basolato – che rendeva il manto stradale “idrorepellente” in modo che i mezzi di trasporto non restassero impantanati in caso di pioggia o neve. Ai lati delle viae erano previsti marciapiedi, alberi che facevano ombra e stazioni di sosta per permettere di riposarsi e fontane dove potersi dissetare.
Le strade erano costruite per durare nel tempo, anche perché nessuno era disposto a pagare troppi sesterzi per ripararle.
Pensate solo al fatto che i lastroni della via Appia sono ancora là, mentre le strade di oggi sono ricoperte di buche.
Chi garantiva l’efficienza delle strade?
L’equivalente della nostra ANAS era il praefectus vehiculorum che aveva il compito di controllare il buon funzionamento del servizio stradale grazie a squadre di curiosi il cui compito era quello di viaggiare e segnalare eventuali disservizi.
Insomma, le strade di Roma erano particolarmente efficienti e la loro gestione era attenta e curata.
Questo ovviamente non toglie il fatto che i viaggi erano comunque lunghi, faticosi e rischiosi.
Per rendere il viaggio più agevole erano previste delle stazioni di sosta e le mutatio, che altro non erano che stazioni di sosta dove poter cambiare cavallo, un servizio utilizzato soprattutto dai cursores, l’equivalente dei nostri postini, un vero e proprio servizio di pony express.
Insomma, a quanto pare le strade a Roma funzionavano, forse meglio di come funzionano oggi, anche se come detto non mancavano i disservizi.