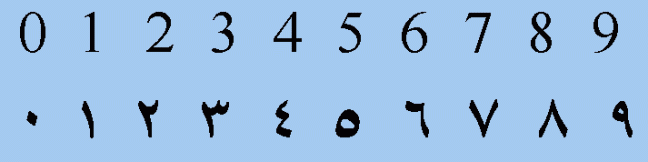
In questi giorni sui social è possibile che abbiate visto un post con la seguente scritta: ” vogliono introdurre i numeri arabi nelle scuole, voi siete d’accordo?” e ci sono commenti ironici su quanto le persone siano ignoranti, ma la domanda è: sappiamo davvero da dove vengono i numeri arabi? Quelli che chiamiamo numeri arabi sono davvero arabi? Perché si decise che era meglio di quelli romani?
Seguiamo le tracce dei numeri arabi…
Quelli che vengono chiamati comunemente numeri arabi sono i numeri che usiamo nella vita di tutti i giorni: 0, 1,2,4,5,6,7,8,9 e sono dette per l’appunto “cifre arabe”, anche se quello su cui noi oggi basiamo i nostri calcoli è un sistema detto “metrico decimale” che è un miglioramento dei numeri arabi.

Le cifre arabe comunque non sono giunte a noi nel modo in cui le scriviamo, ma sono un’evoluzione dei numeri brahmi indiani , i quali dopo innumerevoli trascrizioni per mano di popoli diversi sono arrivati ad essere scritti da noi nel modo in cui li conosciamo.
Ma andiamo con ordine: partiamo dalla storia dei numeri arabi.
Abbiamo visto che né i numeri arabi né il relativo sistema di calcolo che li accompagna è stato inventato dagli arabi, bensì si tratta di un’invenzione indiana che si sviluppa tra il 400 a.C ed il 500 d.C.
Sono chiamati arabi perché la loro diffusione avvenne proprio grazie ad alcuni astronomi arabi.
Tutto ebbe inizio intorno al 650 a.C: un vescovo siriano accenna in un proprio manoscritto ad alcuni simboli con cui il popolo indiano riesce a scrivere ogni numero e fare di conto molto più velocemente di quanto non succeda con i numeri romani.
Durante il califfato di Al-Mamun, nel 772 d.C giunse nella città di Bagdad una delegazione di matematici indiani che portò al Califfo un’opera dove veniva spiegato per filo e per segno come attraverso dieci segni potesse essere possibile scrivere qualsiasi numero e svolgere facilmente i calcoli (l’opera in questione è il Siddantha).
A tale opera attinse l’astronomo arabo Al Khwarizmi, responsabile della biblioteca del Califfo ed autore di numerose opere di astronomia, aritmetica ed algebra.



